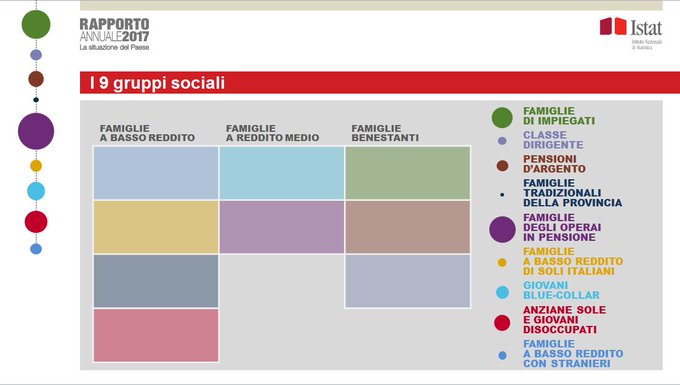Secondo l’ultimo aggiornamento del Global Dividend Index sulle 1.200 maggiori aziende al mondo per capitalizzazione di Borsa, nel 2021 i colossi globali pagheranno agli azionisti 1,39 trilioni di dollari. Intanto l'Economic Policy Institute rileva che nel 2020 i ceo delle 350 maggiori imprese Usa sono stati pagati in media 24,2 milioni di dollari, il 18,9% in più rispetto al 2019, grazie anche alla crescita dell’offerta di azioni nei pacchetti di remunerazione. Dal 1978 al 2020, i loro guadagni dei Ceo sono cresciuti del 1.322%, quelli dei lavoratori medi solo del 18%.
Il contesto economico continua a essere incerto, il monte salari delle aziende stenta a recuperare i livelli pre-pandemia e i sussidi finiscono nel mirino perché secondo gli imprenditori – e qualche politico – “scoraggiano il lavoro”. In un quadro a tinte fosche, l’altro lato della medaglia è vissuto invece da azionisti e amministratori delegati delle più grandi aziende del pianeta: i dividendi hanno ormai quasi chiuso il gap provocato dalla discontinuità pandemica e gli stipendi dei loro amministratori delegati, nell’anno della crisi sanitaria, sono cresciuti a doppia cifra. Con la crescita dell’offerta di azioni nei pacchetti di remunerazione i due gruppi – soci e ad – sempre di più vanno a sovrapporsi, determinando anche distorsioni nella governance, negli obiettivi e nella conduzione delle aziende. E ovviamente un aumento delle disuguaglianze: basti dire che dal 1978 al 2020 i guadagni dei Ceo sono cresciuti del 1.322%, mentre quelli dei lavoratori medi solo del 18 per cento.
Secondo l’ultimo aggiornamento del Global Dividend Index, studio trimestrale del gestore patrimoniale globale Janus Henderson sul pagamento delle cedole agli azionisti delle maggiori aziende del pianeta, dopo un anno di magra i colossi globali hanno riavviato la distribuzione dei dividendi, e nel 2021 saranno pagati 1,39 trilioni di dollari. In crescita rispetto agli 1,36 della precedente edizione dello studio, quasi al livello pre-pandemia. L’84% delle aziende considerate dal gestore patrimoniale ha aumentato o mantenuto stabili i dividendi nel secondo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020, dividendi che nel trimestre sono cresciuti complessivamente del 26,3 per cento. La parte del leone l’ha fatta l’Europa, dove i dividendi sono saliti del 66,4 per cento. Alle sue spalle il Regno Unito (+60,9%), mentre il Giappone (+0,4%) e il Nord America (+5%) in questo frangente temporale solo apparentemente sono rimasti al palo. Risultati eclatanti per il Vecchio Continente, sia perché il secondo trimestre è tradizionalmente l’arco dell’anno in cui le società europee staccano le cedole in un’unica soluzione, sia perché dall’altra parte dell’Atlantico di fatto la distribuzione dei dividendi non si è mai interrotta, nemmeno nelle fasi più delicate della crisi.
L’indice analizza nel dettaglio le 1.200 maggiori aziende al mondo per capitalizzazione di Borsa, che distribuiscono il 90% di tutti i dividendi globali. Le successive 1.800 aziende, nell’insieme considerato, rappresentano solo il 10% complessivo, con effetti dunque limitati sui risultati generali. Per lo stesso principio idealmente paretiano, anche le prime 20 aziende della speciale classifica dell’Index, dunque meno del 2% del totale, distribuiscono il 20% dei dividendi complessivi. Samsung, Nestlé, Rio Tinto, Sberbank e Sanofi sono le 5 società che nel secondo trimestre di quest’anno hanno distribuito più dividendi agli azionisti. Insieme ad Allianz, China Mobile, Microsoft, Axa e AT&T completano le prime 10 posizioni. Queste aziende nel secondo trimestre di quest’anno hanno pagato agli azionisti dividendi per 59,9 miliardi di dollari. Altre cedole per 33,1 miliardi di dollari sono state staccate da Exxon, Apple, Toyota, Basf, Deutsche Telekom, Zurich Insurance, Walmart, HSBC, Credit Agricole e Johnson & Johnson. Secondo gli analisti, la crescita più importante nel periodo considerato ha riguardato le società minerarie, che hanno beneficiato del boom dei prezzi delle materie prime. Anche le società industriali e i produttori di beni di consumo hanno sperimentato una decisa ripresa, nonostante alcuni sotto-settori, come quello del tempo libero, rimangano sotto forte pressione. Le società finanziarie restano invece vincolate alle decisioni dei regolatori e ai limiti imposti in alcune aree del globo alle banche.
Ma non sono solo gli azionisti delle più grandi multinazionali a sorridere, secondo i dati dell’Economic Policy Institute, che ha invece analizzato gli stipendi degli amministratori delegati delle 350 maggiori aziende americane, nell’ultimo anno cresciuti più del mercato borsistico e dei salari dei lavoratori. Due gruppi – azionisti e amministratori delegati – che diventano sempre più coincidenti. Nel 2020, i ceo sono stati pagati in media 24,2 milioni di dollari, il 18,9% in più rispetto al 2019, grazie anche alla crescita dell’offerta di azioni nei pacchetti di remunerazione e all’esercizio di stock option. Nel 2020 il rapporto tra la retribuzione del ceo e quella del lavoratore medio è stato mediamente di 351 a 1, ovvero per ogni dollaro di salario del lavoratore medio, l’amministratore delegato ne ha guadagnati 351. Nel 2019 questo rapporto era di 307 a 1, nel 1989 di 61 a 1, nel 1963 di 21 a 1. Dal 1978 al 2020, i guadagni dei Ceo sono cresciuti del 1.322%, mentre quelli dei lavoratori medi solo del 18 per cento.
“Le paga esorbitante dei Ceo è una delle principali cause dell’aumento della disuguaglianza che potremmo tranquillamente eliminare. I Ceo stanno ottenendo di più grazie al loro potere di fissare gli stipendi e perché gran parte della loro retribuzione (oltre l’80%) è correlata alle azioni di Borsa, non perché stiano aumentando la produttività o posseggano competenze specifiche e molto richieste”, afferma l’Economic Policy Institute. Il think tank ha infatti messo a confronto le retribuzioni dei Ceo anche con i salari dello 0,1% che guadagna di più, ovvero il gruppo di lavoratori che guadagna più del 99,9% degli altri salariati. Nel 2019, ultimo anno di disponibilità dei dati per i migliori salariati, la retribuzione dei Ceo è stata 6,44 volte maggiore dello 0,1% dei più ricchi salariati, un rapporto che nel periodo 1947-1979 si fermava a 3,18 volte. Eppure, anche questo gruppo non è rimasto al palo, e ha visto crescere i propri guadagni dal 1978 al 2019 del 341 per cento. Ma le retribuzioni dei Ceo, nello stesso periodo, sono cresciute ben tre volte tanto.
La maggior parte dei pacchetti retributivi dei Ceo prevede un aumento della paga ogni volta che il valore delle azioni dell’azienda aumenta; cioè, consentono agli amministratori delegati di incassare le stock option indipendentemente dal fatto che l’aumento del valore delle azioni dell’azienda sia stato maggiore rispetto ad altre società dello stesso settore. Allo stesso modo, i premi in azioni aumentano di valore quando il prezzo delle azioni dell’impresa aumenta a seguito di una escalation dei prezzi delle azioni nel mercato borsistico. “Se le tasse sulle società vengono ridotte e i profitti aumentano, portando a prezzi delle azioni più alti, è corretto affermare che i Ceo hanno migliorato le prestazioni delle loro aziende?”, si chiedono retoricamente i ricercatori. Che indicano anche qualche strada da percorrere: aliquote marginali più alte per i redditi dei vertici della piramide, più tasse per le aziende con un rapporto elevato tra retribuzione del Ceo e salario medio del lavoratore, interventi di antitrust e regolatori e voce in capitolo di tutta la compagine azionaria sulle retribuzioni dei top executive.
ILFQ